|
 C’era una volta l’industria o, finalmente, l’industria – un’idea ancora fragile di industria vera e propria – comincia a esistere, ad aver gambe solo adesso in Sardegna? Solo in quest’avvio del Duemila, con le tensioni di sempre nelle fabbriche della petrolchimica che fu, nelle aziende del Sulcis Iglesiente, della zona industriale leader di Portovesme, in quella balneare del Golfo degli Angeli di Cagliari e negli altri territori sardi dove dagli anni Sessanta in poi si è cercato di far sorgere tante ciminiere quanti erano i campanili? Perché dimenticare la sventura di quello stabilimento che doveva svettare tra Bitti e Nule, nell’altipiano di San Giovanni, a mille metri d’altitudine, per trasformare in pullover e sciarpette non la lana delle pecore sarde ma i filati che arrivavano nientemeno dal cuore dell’Africa nera del Camerun? C’era una volta l’industria o, finalmente, l’industria – un’idea ancora fragile di industria vera e propria – comincia a esistere, ad aver gambe solo adesso in Sardegna? Solo in quest’avvio del Duemila, con le tensioni di sempre nelle fabbriche della petrolchimica che fu, nelle aziende del Sulcis Iglesiente, della zona industriale leader di Portovesme, in quella balneare del Golfo degli Angeli di Cagliari e negli altri territori sardi dove dagli anni Sessanta in poi si è cercato di far sorgere tante ciminiere quanti erano i campanili? Perché dimenticare la sventura di quello stabilimento che doveva svettare tra Bitti e Nule, nell’altipiano di San Giovanni, a mille metri d’altitudine, per trasformare in pullover e sciarpette non la lana delle pecore sarde ma i filati che arrivavano nientemeno dal cuore dell’Africa nera del Camerun?
Oggi le liste degli operai, delle mitiche tute blu, si sono sfoltite. Ma la base industriale – dalla grande alla piccola impresa – comincia a viaggiare su cifre più stabili e ragionevoli. C’è da chiedersi infatti se era vera industria quella del petrolio, quella che ipotizzava soltanto nella Media Valle del Tirso ottomila posti di lavoro per fibre di nylon e di poliestere, per acido tereftalico e chips, o se è più solida quella di oggi che garantisce (purtroppo con costante affanno) mille buste paga per produzioni che sicuramente hanno oggi e avranno domani un mercato. A Portotorres si sbandieravano ventimila posti di lavoro (oggi sono poco meno di 2.300). A Ottana avrebbe dovuto sorgere la Siron 2 perché la chiedevano all’accaparratore lombardo Nino Rovelli i sardi della classe dirigente degli anni Settanta. Per fortuna qualcuno si oppose. Pronunciò no anche la parte nobile di un sindacato preveggente. «Non ci ubriacherete con tinozze di virgin nafta», aveva detto il segretario della Cgil di Nuoro Salvatore Nioi scandalizzando non poco lo status quo della politica imperante nel Centro Sardegna e dintorni. A Sarroch, dopo la raffineria della Saras e gli impianti della Nurachem, erano previste le linee per sfornare bioproteine: furono buttati al vento cento miliardi di allora (1972-75) e non se ne fece nulla, diversamente avremmo visto ulteriori cortei di protesta ed esplodere maggiormente gli elenchi dei licenziati e dei cassintegrati. Avvenne lo stesso nel Sarcidano fra Laconi e Isili, per il Sologo tra Lula e Orosei, per la pianura tra Villacidro e San Gavino, per Bolotana a Siniscola, per Macomer e Ozieri. Dovunque, dopo secoli di stentata economia agropastorale, si pensava a ciminiere salvifiche. La cartiera avrebbe dovuto (e potuto, ma con manager meritevoli di questa definizione) concorrere a capovolgere le condizioni dell’umile economia dell’Ogliastra. La cronaca industriale è diventata, anche in questo caso, cronaca giudiziaria. E si resta (per quanto tempo ancora?) in attesa di giudizio.
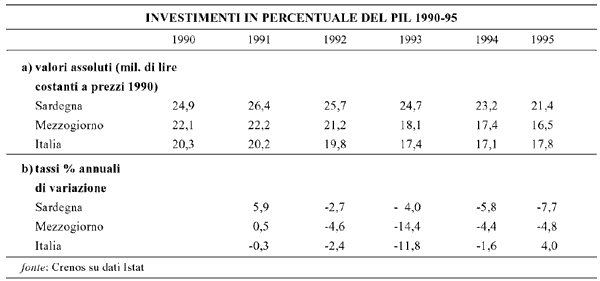
Perché si tenta di sostenere che, forse, la vera fase dell’industrializzazione comincia a essere vissuta solo adesso in Sardegna? Una prima risposta: perché gli stabilimenti industriali sono a misura economica e non più politica, perché gli organici sono quelli necessari alla fabbrica non quelli utilizzabili come serbatoi clientelari di una classe politica che ha sperperato fiumi di risorse pubbliche da girare a industriali amanti del voto di scambio. Solo adesso si può fare una affermazione di questo tipo, con le fabbriche più vuote di addetti. Solo adesso, si è detto. Quindi con un secolo di ritardo sul resto d’Italia, con due secoli di sfasatura dopo l’avvio dell’industrializzazione in Occidente. Proprio perché oggi, dopo le megalomanie del passato, dopo la grande espansione (non produttiva) dell’agropastorizia e di un commercio avvitato su stesso, si instaura una vera cultura socio-industriale, si inizia a ragionare in termini di fatturato e di mercato, di esportazione e di qualità, di precisione nelle lavorazioni e di puntualità nelle consegne. È una metamorfosi che si coglie nelle grandi e nelle piccole e medie fabbriche, nei manager in doppiopetto e in più modesti capi officina in jeans e maglietta. Solo adesso, sostiene il sociologo dell’economia Gianfranco Bottazzi, preside della facoltà di Scienze Politiche di Cagliari, si cominciano a intravedere gli «effetti di socializzazione, di diffusione cioè di una cultura industriale e delle sue significative conseguenze». Ciò avviene dopo quarant’anni affannosi di avventura industriale. In un libro destinato ad aver fortuna, edito in questi giorni dalla Cuec, Eppur si muove, Bottazzi affronta col rigore della scienza quella che lui definisce la debolezza della cultura industriale in Sardegna. Nel «processo accelerato di modernizzazione della struttura occupazionale» sarda, lo studioso sostiene quanto aveva già scritto nel 1992 nel dossier Mercato del lavoro e sviluppo economico in Sardegna: che si è trattato cioè «di un vero e proprio salto di una fase che ha fatto sì che la Sardegna sia diventata post-industriale senza essere mai stata compiutamente industriale».
 Ma è proprio in questa fase post-industriale che si può aver maggiore fiducia rispetto alle follie, ai castelli di sabbia del passato. Cominciano a imporsi gruppi industriali di seconda e di terza generazione. L’agropastorizia è diventata agroindustria e sa di potersi reggere soltanto se il pecorino continua a essere piazzato negli Stati Uniti e in Canada, se l’olio dei Cosseddu e dei Manca raggiungono i ristoranti di Londra e Parigi, se il vino di Argiolas, Sella e Mosca e Meloni proseguono la loro strada in Giappone, nel nord-Europa e in Francia. La mentalità industrale sta cominciando, oggi, ad aver gambe. Ma è proprio in questa fase post-industriale che si può aver maggiore fiducia rispetto alle follie, ai castelli di sabbia del passato. Cominciano a imporsi gruppi industriali di seconda e di terza generazione. L’agropastorizia è diventata agroindustria e sa di potersi reggere soltanto se il pecorino continua a essere piazzato negli Stati Uniti e in Canada, se l’olio dei Cosseddu e dei Manca raggiungono i ristoranti di Londra e Parigi, se il vino di Argiolas, Sella e Mosca e Meloni proseguono la loro strada in Giappone, nel nord-Europa e in Francia. La mentalità industrale sta cominciando, oggi, ad aver gambe.
Ma prendiamo in considerazione alcuni territori sicuramente abituati ormai a convivere con la grande industria. Il Sulcis non è più quello delle miniere mangiasoldi, delle sigle inventate per distribuire salari soprattutto improduttivi. La zona industriale di Portovesme si è trasformata in un polo di alta tecnologia, ha un fatturato complessivo di circa duemila miliardi, può competere nel mercato internazionale proprio perché si è globalizzata. Lo stabilimento dell’americana Alcoa, diretto da manager sardissimi, è stato giudicato lo scorso anno l’impianto number one al mondo per efficienza. Lì è stato sperimentato l’anodo combustibile che potrebbe dar vita a una tecnologia innovativa a livello planetario. È stato superato (in questo caso, miracolosamente e consapevolmente, senza un giorno solo di scioperi) il concetto delle aziende a partecipazione statale. Gli ex impianti Eni sono passati al colosso svizzero della Glencore, uno dei giganti mondiali della metallurgia. Ciminiere che stanno vedendo in quest’inverno una massa di investimenti che lo renderanno il primo stabilimento dell’area del Mediterraneo e dell’intera Europa. L’Eurallumina è posseduta dalla Comalco australiana e va meglio di quando la sostentavano i ministri democristiani e socialisti che furono. Anche l’ex Comsal ha perso le casacche statali (Efim) e ha tra i suoi nuovi proprietari (con Orlandi) il gruppo privato Molinas di Calangianus, l’omonima azienda che, con aziende in Gallura, nel nord Italia e in Portogallo, trasforma il sughero e lo commercializza nel mondo.
Meno ottimistico è il quadro dell’industria chimica, anche se la qualità delle produzioni si sta imponendo solo adesso. A Portotorres sono previsti massicci investimenti nel settore del fenolo, anche Sarroch (con la Saras e la Nurachem) viaggia su produzioni di qualità che hanno mercato. Molto più incerto il futuro per Ottana e Macchiareddu dove non si riesce ancora a prospettare un futuro certo con qualche innovazioni di prodotto e di processo. Restano le speranze per i già stipulati contratti d’area del Sulcis, di Portotorres e di Ottana per evitare di disegnare solo scenari più o meno neri o grigi. Molto grande il punto interrogativo attorno ad Arbatax (tanto per la cartiera quanto per l’Intermare), meno pessimismo su alcune iniziative avviate e da potenziare nella zona di Villacidro-San Gavino.
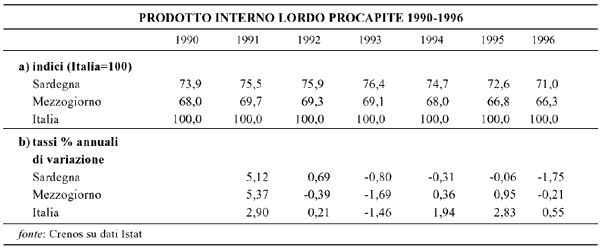
Ma, a parte questi grandi impianti, resta da dire che quel poco di piccola e media industria sopravvissuta alla crisi della petrolchimica e delle Partecipazioni statali, comincia a consolidarsi. Il distretto gallurese del granito e del sughero regge e si espande. A Calangianus i “meccanici del sughero” cominciano a costruire macchinari da piazzare nei mercati internazionali. Orosei, con i marmi, continua ad avere la sua risorsa principale nella trasformazione dei lapidei che varcano ugualmente il mare. La zona industriale di Macomer, a parte sofferenze congiunturali, assicura produzioni di pregio e poco meno di un migliaio di buste paga. Anche Nuoro, con i modesti insediamenti di Pratosardo, ha oggi meno angosce che in passato e si sta formando una classe dirigente industriale che impiega il suo tempo a cercar mercati e non più a far la fila davanti agli uffici dell’assessore all’Industria di turno.
 Tutto ciò può bastare? Certo che no. Basterebbe del resto sfogliare la collezione degli ultimi vent’anni di questa rivista (che ha sicuramente occupato uno spazio autorevole nel campo dell’informazione economica in Sardegna) per documentare le fasi di un processo tormentato dell’industrializzazione sarda. Iniziative tante, ma con una programmazione abborracciata, grossolana, senza uno studio per il collocamento nel mercato di produzioni lontane anni luce dalla storia e dalla tradizione nuragica. Il problema è oggi quello di consolidare l’esistente ampliando la base produttiva che è ancora debole, molto debole. Se osserviamo queste tabelle tratte da una ricerca del professor Raffaele Paci del Crenos dell’Università di Cagliari tocchiamo con mano la debolezza del nostro sistema economico Dal 1993 il pil pro capite (prodotto interno lordo) è in costante caduta mentre si allarga il fossato col resto del Paese. Sono in diminuzione anche gli investimenti in percentuale del prodotto interno lordo. Tutto ciò può bastare? Certo che no. Basterebbe del resto sfogliare la collezione degli ultimi vent’anni di questa rivista (che ha sicuramente occupato uno spazio autorevole nel campo dell’informazione economica in Sardegna) per documentare le fasi di un processo tormentato dell’industrializzazione sarda. Iniziative tante, ma con una programmazione abborracciata, grossolana, senza uno studio per il collocamento nel mercato di produzioni lontane anni luce dalla storia e dalla tradizione nuragica. Il problema è oggi quello di consolidare l’esistente ampliando la base produttiva che è ancora debole, molto debole. Se osserviamo queste tabelle tratte da una ricerca del professor Raffaele Paci del Crenos dell’Università di Cagliari tocchiamo con mano la debolezza del nostro sistema economico Dal 1993 il pil pro capite (prodotto interno lordo) è in costante caduta mentre si allarga il fossato col resto del Paese. Sono in diminuzione anche gli investimenti in percentuale del prodotto interno lordo.
La tendenza va invertita. Come? Contribuendo a diffondere, come purtroppo è avvenuto e sta ancora avvenendo in Sardegna, messaggi gridati di antindustrialismo? Continuando a pensare che dire industria sia dire reato?
Per fortuna, soprattutto negli anni Ottanta, la Sardegna ha cominciato a pensare alle tecnologie della conoscenza e dell’informatica. Sono sorti alcuni centri di ricerca che hanno contribuito, e stanno contribuendo, a dare un volto nuovo all’industria isolana. C’è, più di prima, capacità di fare industria ed è evidente che anche gli errori del passato qualche segno positivo lo hanno pur lasciato sul campo. C’è, insomma, una Sardegna industriale che si muove. Nelle conclusioni del suo libro, sottolineando il distacco notevole tra Sardegna e zone ricche del Paese, Bottazzi sostiene: «Occorre ricordare che le regioni del Centro e soprattutto del Nord – alcune di esse in particolare – hanno conosciuto, dal dopoguerra a oggi, tassi di crescita del prodotto interno lordo, quindi del reddito disponibile e dei consumi, di assoluto rilievo, tra i più alti del mondo. Non è un caso se oggi regioni come la Lombardia, il Piemonte, l’Emilia Romagna sono fra le regioni più ricche dell’Unione europea. Ora, riprendendo una osservazione che Paolo Sylos Labini avanzava acutamente qualche anno fa, il fatto che il divario fra la Sardegna e le regioni settentrionali non sia diminuito, ma neanche aumentato, è la dimostrazione che, almeno per quanto riguarda la quantità di reddito disponibile, la Sardegna ha tenuto il passo delle regioni con le migliori performances tra i Paesi occidentali del dopoguerra. Questo è un dato di assoluto rilievo: negli ultimi cinquant’anni, certo con contraddizioni, la Sardegna ha tenuto il passo delle regioni più avanzate d’Europa, quanto a crescita della ricchezza disponibile, del livello dei consumi, degli indicatori che testimoniano delle condizioni di vita, dalla durata della vita media alla scolarità, dalle dotazioni sanitarie alla mortalità infantile. Ovviamente questa constatazione non può indurre ad alcun passivo compiacimento, né c’è in effetti alcuna fondata ragione per atteggiamenti trionfalistici. Perché – è ancora Bottazzi che parla – restano le distorsioni, le insufficienze (quelle dei posti di lavoro in primo luogo), la sostanziale dipendenza dall’esterno dell’economia sarda, la mancanza di un meccanismo di sviluppo che si autoalimenti. Ma la Sardegna non è immobile, niente è più come prima. Anche se, per cogliere e comprendere meglio le valenze di questo mutamento, abbiamo bisogno di analisi meno convenzionali e meno lamentose».
C’è da domandarsi se la Sardegna avrebbe conosciuto questa veloce metamorfosi senza quella contestata industrializzazione. La risposta è no, perché una Sardegna agropastorale era a livelli polifemaici anche negli anni Cinquanta e non avrebbe potuto dare quello scatto di reni che le ciminiere le hanno dato.
 Il futuro? Il futuro si chiama ancora industria. Certo non pesante, certo non petrolchimica, certo non mineraria e metallurgica. Il futuro è industria turistica, industria tecnologica, informatica. Il successo di Tiscali insegna molte cose alla Sardegna dello scetticismo e della lamentazione. Il futuro è nella conoscenza più diffusa, nelle più accentuata scolarizzazione. Il futuro? Il futuro si chiama ancora industria. Certo non pesante, certo non petrolchimica, certo non mineraria e metallurgica. Il futuro è industria turistica, industria tecnologica, informatica. Il successo di Tiscali insegna molte cose alla Sardegna dello scetticismo e della lamentazione. Il futuro è nella conoscenza più diffusa, nelle più accentuata scolarizzazione.
Il futuro è nella capacità di saper collegare lo sviluppo della fragile struttura industriale dell’Isola alla crescita dei Paesi del mediterraneo, non solo di quelli vicini dell’Africa ma di tutti gli Stati più interni di un Continente come l’Asia che dovrà uscire dall’arretratezza medioevale e che potrebbe avere anche nella Sardegna uno dei suoi centri propulsori, uno dei ponti con l’Europa. (Ma il porto canale del mito e dello spreco diventerà il porto canale dei traffici internazionali?).
Il futuro, lo ha detto bene nelle pagine precedenti Paolo Savona, sta nella consapevolezza dell’importanza dei mercati esteri, dell’export, del saper competere col mondo. Gli esempi ci vengono dalla grande industria localizzata in Sardegna e che ha saputo restare in piedi. Vive di export la Sardegna che trasforma i suoi prodotti agroalimentari e li piazza nei supermercati del mondo. Ciò avviene nel rispetto delle leggi di mercato, dell’equilibrio fra domanda e offerta. Senza la droga dei contributi politici, assistenziali. Anche per questa consapevolezza che si va diffondendo in Sardegna, c’è spazio per l’ottimismo. Partendo dal rilancio dell’industria: che è necessaria alla Sardegna proprio per distruggere quel flagello di nome disoccupazione.
|

